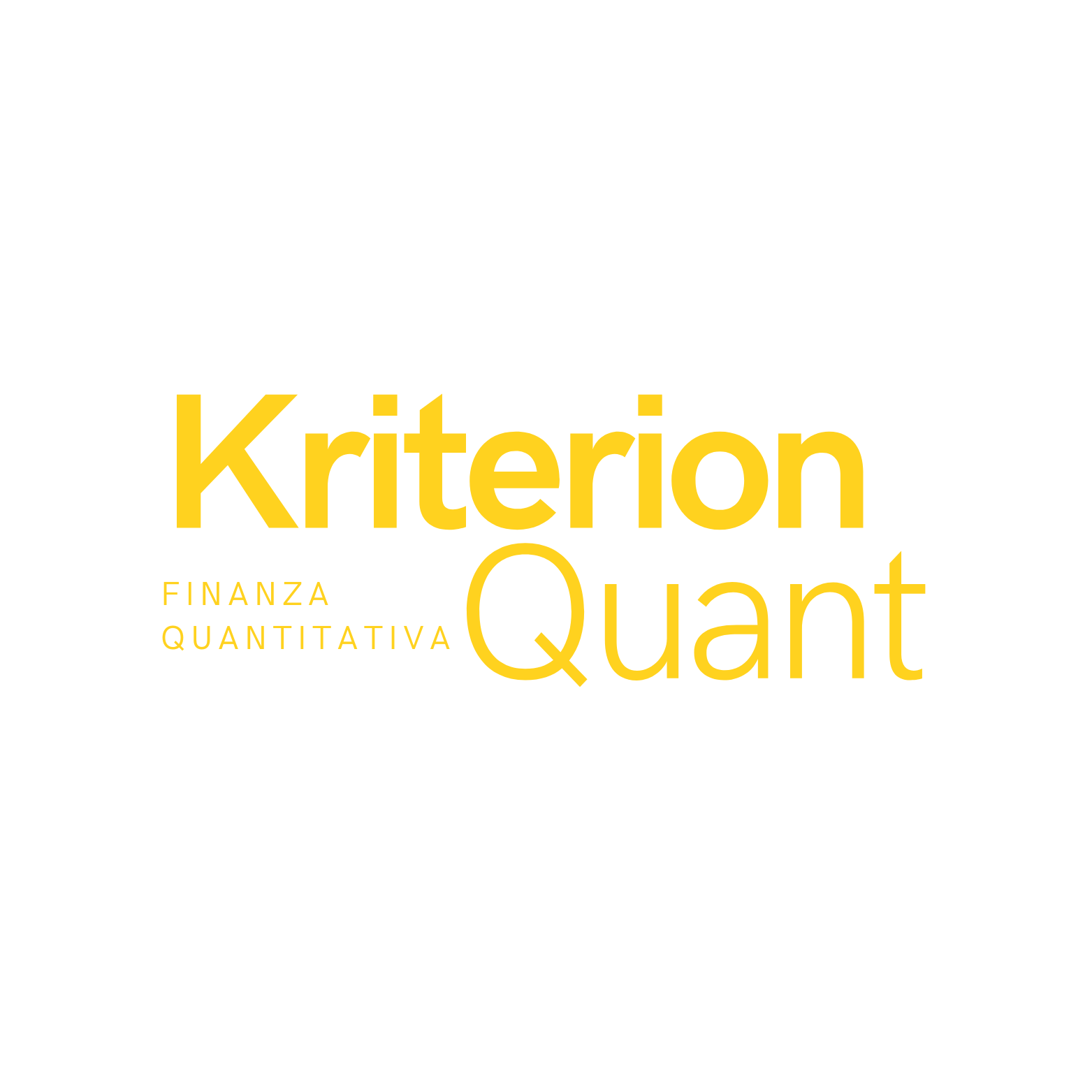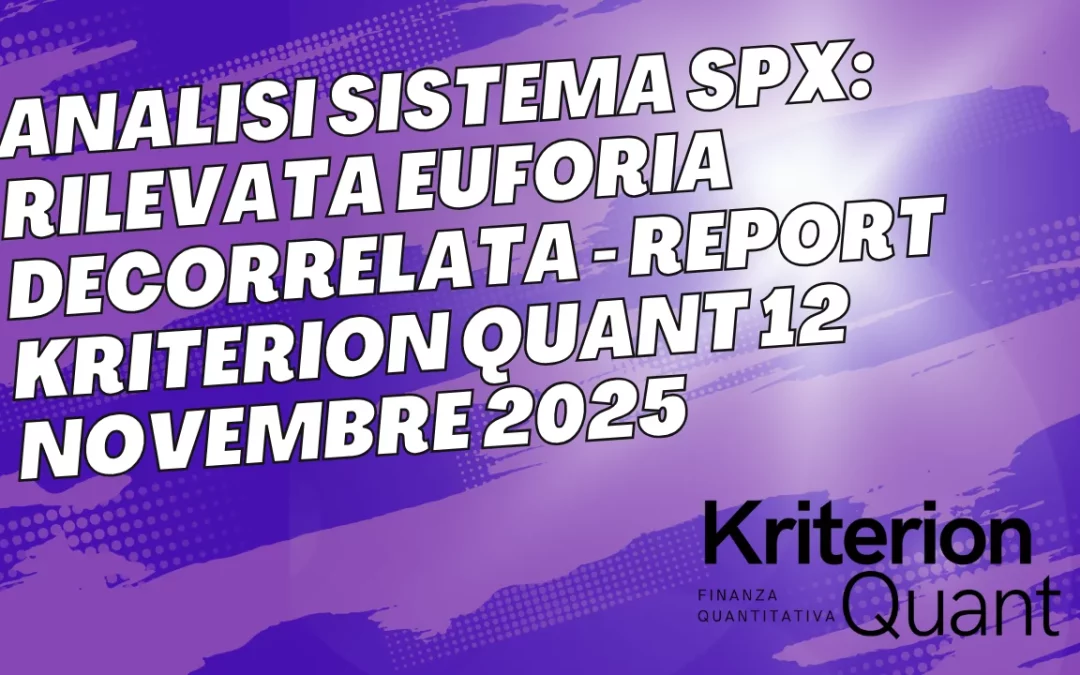Introduzione: Oltre l’Universo Parallelo degli Investitori
Nel cuore della teoria finanziaria e della presa di decisioni in condizioni di incertezza si cela una domanda fondamentale: come dovrebbe un individuo razionale valutare un’opportunità rischiosa?
Per decenni, la risposta è stata dominata dal calcolo del valore atteso, una media ponderata di tutti i possibili risultati futuri. Questo approccio, radicato nella teoria della probabilità e formalizzato nella Teoria dell’Utilità Attesa (EUT), immagina implicitamente un insieme di universi paralleli in cui ogni possibile esito si realizza, per poi calcolare la media dei risultati su questo insieme. Ma cosa succede se un investitore vive in un solo universo, lungo una singola e irripetibile traiettoria temporale? Cosa succede se alcuni percorsi portano alla rovina, uno stato da cui non c’è ritorno?
È qui che entra in gioco il concetto di ergodicità, un’idea potente importata dalla fisica statistica del XIX secolo che sta scuotendo le fondamenta della teoria economica tradizionale. L’ergodicità esprime l’idea che, in certi sistemi, la media del comportamento di un singolo elemento nel tempo (media temporale) è equivalente alla media del comportamento di un vasto insieme di elementi in un singolo istante (media d’insieme). L’ipotesi che i processi economici e finanziari siano ergodici è stata un pilastro, spesso implicito, su cui si è costruita gran parte dell’econometria e della teoria della decisione del XX secolo. Tuttavia, un crescente corpus di ricerca, noto come Ergodicity Economics (EE), sostiene che questa assunzione sia fondamentalmente errata quando applicata ai mercati finanziari. I mercati, caratterizzati da dinamiche di crescita moltiplicativa e dalla presenza di barriere assorbenti come il fallimento, sarebbero sistemi intrinsecamente non-ergodici. In questi sistemi, la media d’insieme e la media temporale divergono radicalmente, portando a conclusioni diametralmente opposte su ciò che costituisce una decisione razionale.
Questo articolo si propone di esplorare in modo esaustivo il concetto di ergodicità e le sue profonde implicazioni per i mercati finanziari. Partiremo dalle sue origini nella fisica di Ludwig Boltzmann, per poi formalizzarne i concetti matematici chiave. Analizzeremo come la distinzione tra medie d’insieme (aritmetiche) e medie temporali (geometriche) ridefinisca la nostra comprensione del rischio e della crescita. Esamineremo criticamente come l’assunzione implicita di ergodicità abbia plasmato la teoria economica tradizionale, in particolare la Teoria dell’Utilità Attesa. Successivamente, approfondiremo il programma di ricerca dell’Ergodicity Economics, le sue soluzioni a noti paradossi economici e il vivace dibattito accademico che ha scatenato, incluse le severe critiche che ne contestano la novità e lo status scientifico. Infine, ci tufferemo nell’analisi empirica, esaminando le evidenze di (non)ergodicità nelle serie storiche finanziarie e le sue conseguenze pratiche per la gestione del rischio, l’uso della leva finanziaria e la costruzione di modelli di mercato più realistici.
Parte I: Fondamenti Concettuali dell’Ergodicità
1.1. Origini e Definizioni: Il Ponte tra Fisica e Probabilità
L’Ipotesi Ergodica in Meccanica Statistica
Il concetto di ergodicità nasce dalla necessità di risolvere un problema apparentemente insormontabile nella fisica del XIX secolo. Ludwig Boltzmann, uno dei padri fondatori della meccanica statistica, si trovò di fronte alla sfida di collegare il mondo microscopico, governato dal moto caotico di un numero inimmaginabile di particelle (i microstati), con il mondo macroscopico delle proprietà osservabili come pressione e temperatura (il macrostrato). Seguire la traiettoria di ogni singola particella era, ed è tuttora, computazionalmente impossibile. Per superare questo ostacolo, Boltzmann formulò l’ipotesi ergodica. L’ipotesi postula che, per un sistema isolato in equilibrio, una singola traiettoria del sistema nello spazio delle fasi (uno spazio astratto where ogni punto rappresenta un unico microstato, definito dalle posizioni e dai momenti di tutte le particelle) passerà, dato un tempo sufficientemente lungo, arbitrariamente vicino a ogni altro microstato compatibile con la sua energia totale. In termini più semplici, il sistema esplora in modo uniforme e imparziale tutta la superficie di energia accessibile.
La conseguenza rivoluzionaria di questa ipotesi è l’equivalenza tra due tipi di medie:
- La media temporale (Time Average): La media di una qualsiasi grandezza fisica, calcolata seguendo la traiettoria di una singola particella per un tempo teoricamente infinito.
- La media d’insieme (Ensemble Average): La media della stessa grandezza calcolata su un insieme (o ensemble) di tutte le possibili configurazioni microscopiche del sistema in un singolo istante di tempo.
Questa equivalenza rappresenta una semplificazione concettuale e computazionale di portata immensa. Permette di sostituire un calcolo dinamico e temporale, altrimenti intrattabile, con un calcolo statistico su un insieme di stati simultanei. L’ipotesi ergodica, quindi, giustifica l’uso degli insiemi statistici per derivare le proprietà termodinamiche di sistemi complessi come i gas, where si presume che le continue collisioni tra particelle mescolino il sistema, portandolo a esplorare rapidamente tutti gli stati accessibili.
Formalizzazione Matematica
La teoria ergodica, come disciplina matematica, fornisce un quadro rigoroso per le idee intuitive di Boltzmann, collocandosi all’intersezione tra la teoria dei sistemi dinamici e la teoria della probabilità. Un sistema dinamico è formalmente descritto da una quadrupla $(X, \Sigma, \mu, T)$:
- $X$ è lo spazio degli stati (l’equivalente dello spazio delle fasi).
- $\Sigma$ è una σ-algebra di sottoinsiemi misurabili di $X$.
- $\mu$ è una misura di probabilità invariante, con $\mu(X)=1$.
- $T: X \rightarrow X$ è una trasformazione che preserva la misura, ovvero $\mu(T^{-1}(A)) = \mu(A)$ per ogni sottoinsieme misurabile $A$.
La trasformazione $T$ descrive l’evoluzione del sistema in un passo temporale. In questo contesto, la trasformazione $T$ si dice ergodica se ogni insieme $A \in \Sigma$ che è invariante sotto $T$ (cioè, $T^{-1}(A) = A$) ha misura 0 o 1. Questa definizione, apparentemente astratta, ha una conseguenza profonda: un sistema ergodico non può essere decomposto in sottoinsiemi invarianti più piccoli e non banali. La dinamica mescola l’intero spazio in modo tale che una traiettoria iniziata in una qualsiasi regione non rimarrà confinata in una sua sottoporzione, ma visiterà eventualmente ogni parte dello spazio. Il risultato centrale della teoria è il teorema ergodico di Birkhoff, che formalizza l’equivalenza tra le medie. Esso afferma che per un sistema ergodico, la media temporale di una funzione integrabile $f$ lungo quasi ogni traiettoria converge alla media spaziale (o valore atteso) della funzione rispetto alla misura invariante $\mu$:
$$ \lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n(x)) = \int_X f \, d\mu $$Il lato sinistro dell’equazione rappresenta la media temporale lungo una singola traiettoria che parte dal punto $x$. Il lato destro rappresenta la media spaziale o d’insieme, calcolata sull’intero spazio degli stati. Questa equazione è il cuore matematico del concetto di ergodicità.
1.2. Rottura dell’Ergodicità e Concetti Correlati
Non tutti i sistemi, tuttavia, sono ergodici. La rottura dell’ergodicità (ergodicity breaking) si verifica quando un sistema non riesce a esplorare l’intero spazio delle fasi accessibile nel corso della sua evoluzione. Questo fenomeno è comune in sistemi complessi e disordinati. Un esempio classico in fisica è quello dei vetri di spin, where il sistema può rimanere intrappolato in specifiche valli di energia per tempi estremamente lunghi, violando l’ipotesi che tutti gli stati siano equiprobabili. Un concetto strettamente legato alla rottura dell’ergodicità è la dipendenza dal percorso (path dependence). In un sistema non ergodico, la storia conta (history matters). L’esito a lungo termine di un sistema dipende in modo cruciale non solo dalle condizioni iniziali, ma anche dalla sequenza specifica di eventi (la traiettoria) che il sistema ha seguito. Scelte basate su condizioni transitorie possono avere effetti persistenti e talvolta irreversibili.
Una delle cause più rilevanti di rottura dell’ergodicità, specialmente in contesti economici e finanziari, è la presenza di barriere assorbenti. Si tratta di stati del sistema dai quali non è possibile uscire una volta entrati. L’esempio più emblematico nel mondo finanziario è la rovina, ovvero la perdita totale del capitale (un rendimento del -100%). Un investitore che raggiunge questo stato è permanentemente escluso dal gioco; la sua traiettoria termina senza aver potuto esplorare tutti gli altri possibili risultati. Qualsiasi sistema che ammetta anche solo una remota possibilità di rovina è, per definizione, non ergodico, poiché esistono traiettorie che vengono assorbite e non possono più partecipare alla dinamica complessiva. L’esempio della roulette russa illustra vividamente questo punto. Anche se si vince un’ingente somma di denaro a ogni round vinto (sopravvissuto), l’esito a lungo termine per un singolo giocatore che gioca ripetutamente non è un arricchimento infinito, ma la morte certa. La barriera assorbente della morte impedisce al giocatore di realizzare la media dei guadagni calcolata su un insieme di giocatori che giocano una sola volta. L’obiettivo primario in un sistema del genere non è massimizzare la performance, ma garantire la sopravvivenza per poter continuare a giocare.
1.3. Medie a Confronto: Aritmetica vs. Geometrica in Dinamiche Additive e Moltiplicative
La Divergenza Fondamentale
La distinzione tra sistemi ergodici e non ergodici si manifesta in modo tangibile nella divergenza tra due metodi di calcolo della media: la media d’insieme e la media temporale.
Media d’Insieme (Ensemble Average): Corrisponde al concetto statistico di valore atteso o media aritmetica. Viene calcolata considerando tutti i possibili risultati di un processo in un dato istante e ponderandoli per le rispettive probabilità. È un’operazione che si svolge nello spazio, attraverso un insieme di realizzazioni parallele o universi controfattuali.
Media Temporale (Time Average): Descrive il risultato tipico di una singola traiettoria che si evolve nel tempo. Per i processi che implicano crescita o decrescita composta, come gli investimenti finanziari, la metrica appropriata per la media temporale è la media geometrica dei fattori di crescita. È un’operazione che si svolge nel tempo, lungo una singola storia di vita.
In un sistema ergodico, queste due medie convergono allo stesso valore per tempi e insiemi sufficientemente grandi. In un sistema non ergodico, invece, possono divergere radicalmente, portando a conclusioni opposte riguardo al comportamento atteso del sistema.
Illustrazione con il Gioco Moltiplicativo
La differenza tra queste due medie e le sue profonde implicazioni per la finanza può essere illustrata con un semplice ma potente esperimento mentale: un gioco di lancio di moneta con dinamica moltiplicativa. Si supponga di avere un capitale iniziale $x(t)$ e di partecipare a un gioco ripetuto:
- Se esce testa (probabilità 50%), il capitale aumenta del 50% (viene moltiplicato per 1.5).
- Se esce croce (probabilità 50%), il capitale diminuisce del 40% (viene moltiplicato per 0.6).
Per valutare se partecipare a questo gioco sia una scelta razionale, si possono utilizzare le due diverse medie:
Analisi tramite Media d’Insieme (Valore Atteso)
Il valore atteso del capitale dopo un singolo lancio è calcolato come media aritmetica dei possibili risultati: $E[x(t+1)] = 0.5 \times (1.5 \cdot x(t)) + 0.5 \times (0.6 \cdot x(t)) = (0.75 + 0.3) \cdot x(t) = 1.05 \cdot x(t)$. Secondo questa metrica, il gioco è estremamente favorevole: in media, su un grande insieme di giocatori, il capitale cresce del 5% a ogni lancio. La teoria economica tradizionale, basata sul valore atteso, concluderebbe che rifiutare questo gioco è irrazionale.
Analisi tramite Media Temporale (Crescita Tipica)
Consideriamo ora cosa accade a un singolo giocatore che partecipa ripetutamente. Dopo due lanci, uno testa e uno croce (l’esito più probabile nel lungo periodo), il suo capitale sarà: $x(t+2) = x(t) \times 1.5 \times 0.6 = 0.9 \cdot x(t)$. Il capitale è diminuito del 10%. Il tasso di crescita tipico per lancio, nel lungo periodo, è dato dalla media geometrica dei fattori di crescita: $\bar{r}_T = \sqrt{1.5 \times 0.6} = \sqrt{0.9} \approx 0.9487$. Secondo questa metrica, il gioco è disastroso: un singolo giocatore che partecipa ripetutamente vedrà il suo capitale erodersi di circa il 5.13% a ogni lancio, con una probabilità che tende a 1 nel lungo periodo.
Questo esempio dimostra in modo lampante la rottura dell’ergodicità: la media di ciò che accade a un insieme di giocatori (crescita del 5%) è l’opposto di ciò che accade a un tipico giocatore nel tempo (decrescita del 5.13%). La fallacia consiste nell’applicare la media d’insieme (aritmetica) per prevedere l’esito di una singola traiettoria temporale in un sistema non ergodico e moltiplicativo.
La Dinamica Determina la Media Corretta
Questa analisi rivela una comprensione più profonda: non si tratta di stabilire quale media sia universalmente corretta, ma di riconoscere che la natura fisica del processo determina quale metrica sia rilevante per un agente che vive lungo una singola traiettoria temporale.
- Dinamiche Additive: In un processo additivo, where gli shock si sommano e non si compongono (es. ricevere uno stipendio fisso), la ricchezza è un osservabile ergodico. In questi sistemi, la media aritmetica (il valore atteso) è un predittore affidabile del risultato a lungo termine per un singolo individuo.
- Dinamiche Moltiplicative: In un processo moltiplicativo, where gli shock si compongono (es. i rendimenti degli investimenti), la ricchezza è un osservabile intrinsecamente non ergodico. Per un singolo investitore, la cui sopravvivenza e crescita dipendono dalla sua traiettoria unica e irripetibile, la metrica rilevante non è il rendimento atteso in un singolo periodo, ma il tasso di crescita composto nel lungo periodo, che è correttamente catturato dalla media geometrica.
Questa distinzione costituisce il punto di rottura fondamentale tra l’economia tradizionale, che ha storicamente privilegiato il valore atteso come metrica universale, e l’approccio dell’Ergodicity Economics.
Parte II: L’Ergodicità nell’Arena Economica e Finanziaria
2.1. L’Assioma Nascosto: L’Uso del Valore Atteso nella Teoria Economica Tradizionale
L’Influenza di Samuelson e l’Ergodic Axiom
L’adozione, spesso implicita, dell’ipotesi ergodica nell’economia del XX secolo è stata fortemente influenzata dal lavoro dell’economista premio Nobel Paul Samuelson. Egli sostenne che l’ipotesi ergodica fosse un prerequisito fondamentale per trasformare l’economia da una disciplina puramente storica a una scienza in grado di formulare leggi generali, analogamente alla fisica. L’idea di fondo era che, se i processi economici fossero ergodici, allora le medie calcolate su dati storici (medie temporali) potrebbero essere utilizzate per inferire le leggi probabilistiche sottostanti (medie d’insieme) e, di conseguenza, per prevedere il futuro. Questa assunzione, definita Ergodic Axiom, postula che la media temporale di un osservabile economico sia sempre uguale al suo valore atteso. Questa prospettiva ha fornito una giustificazione metodologica cruciale per l’econometria delle serie storiche e per la costruzione di modelli macroeconomici. Tuttavia, come evidenziato dai critici, questa assunzione è stata importata dalla fisica dei sistemi chiusi e in equilibrio e applicata acriticamente a sistemi aperti, dinamici e in crescita come le economie e i mercati finanziari, che sono intrinsecamente lontani dall’equilibrio.
Implicazioni per la Teoria dell’Utilità Attesa (EUT)
La Teoria dell’Utilità Attesa (Expected Utility Theory – EUT) è il paradigma dominante per la modellizzazione delle decisioni in condizioni di incertezza sin dalla sua formalizzazione da parte di John von Neumann e Oskar Morgenstern, basata su intuizioni precedenti di Daniel Bernoulli. Di fronte al fallimento del modello basato sulla massimizzazione del valore atteso della ricchezza (esemplificato dal Paradosso di San Pietroburgo), Bernoulli propose che gli individui non massimizzano il valore atteso della ricchezza, bensì il valore atteso dell’utilità della ricchezza. L’introduzione di una funzione di utilità $u(x)$, tipicamente concava ($u”(x) < 0$), permette di modellare l’avversione al rischio: l’utilità di un guadagno addizionale è inferiore alla disutilità di una perdita di pari entità. Sebbene l’EUT rappresenti un significativo passo avanti, il suo apparato matematico rimane ancorato al calcolo di un valore atteso, ovvero una media d’insieme. La decisione ottimale è quella che massimizza $E[u(x)] = \sum_i p_i u(x_i)$. Di conseguenza, l’EUT eredita l’assunzione implicita di ergodicità: presuppone che la media delle utilità su un insieme di risultati possibili sia la metrica rilevante per un individuo la cui traiettoria si svilupperà nel tempo. L’analisi rimane fondamentalmente atemporale, focalizzata su una valutazione statica delle probabilità in un singolo istante, senza considerare esplicitamente come i risultati si compongano lungo una traiettoria temporale.
La Fallacia Ergodica
L’applicazione indiscriminata dell’ipotesi ergodica e del calcolo del valore atteso a sistemi che non soddisfano le condizioni di ergodicità è stata definita la Fallacia Ergodica. Questa fallacia consiste nel credere, erroneamente, che le medie calcolate su un insieme di possibili esiti paralleli (ensemble average) siano una guida affidabile per un agente individuale che sperimenta una sola sequenza di eventi nel tempo (time average). Nei mercati finanziari, questa fallacia ha conseguenze profonde. Modelli come la Teoria Moderna del Portafoglio (Modern Portfolio Theory) e i modelli di valutazione basati sui flussi di cassa scontati (Discounted Cash Flow – DCF) si fondano su stime di rendimenti attesi che sono, nella loro essenza, medie d’insieme. Questi modelli possono essere utili in periodi di relativa stabilità, ma tendono a sottostimare drasticamente i rischi in sistemi non ergodici, where la dipendenza dal percorso e la possibilità di eventi estremi e irreversibili (come i crolli di mercato) sono dominanti.
2.2. Il Programma di Ricerca: Ergodicity Economics (EE)
In risposta a quella che percepisce come una fondamentale inadeguatezza della teoria economica neoclassica, è emerso un nuovo programma di ricerca noto come Ergodicity Economics (EE). Guidato principalmente dal fisico Ole Peters, ricercatore presso il London Mathematical Laboratory e il Santa Fe Institute, questo approccio si propone di rifondare la teoria della decisione su basi dinamiche, mettendo al centro la questione dell’ergodicità.
Principi Fondamentali
Il principio cardine dell’EE è la sostituzione dell’assioma di massimizzazione del valore atteso (dell’utilità) con un nuovo postulato: gli agenti economici agiscono per massimizzare il tasso di crescita temporale della loro ricchezza. L’argomentazione è tanto fisica quanto filosofica: per un individuo, la cui esistenza è legata a una singola e irripetibile traiettoria storica, la media dei risultati su un insieme di sé stessi in universi paralleli è un costrutto matematico irrilevante. Ciò che determina la sua sopravvivenza e il suo successo a lungo termine è la performance cumulativa della sua specifica traiettoria nel tempo. In contesti di crescita moltiplicativa, questo tasso di crescita temporale è correttamente catturato dalla media geometrica dei rendimenti, non dalla media aritmetica. L’EE, quindi, sposta il focus dall’analisi statica delle probabilità all’analisi dinamica della crescita lungo un percorso.
La Trasformazione Ergodica
Per rendere operativi questi principi, l’EE introduce il concetto di trasformazione ergodica. Data una grandezza non ergodica, come la ricchezza $x(t)$ in un processo moltiplicativo, la trasformazione ergodica è una funzione matematica $v(x)$ tale per cui la nuova variabile $v(x(t))$ diventa un osservabile ergodico, il cui valore atteso cresce linearmente nel tempo. Questo permette di calcolare un tasso di crescita ben definito. Per il moto Browniano geometrico, il modello stocastico standard per i prezzi delle attività finanziarie, la trasformazione ergodica è la funzione logaritmica ($v(x) = \ln(x)$). Massimizzare il tasso di crescita temporale della ricchezza in questo modello è matematicamente equivalente a massimizzare il valore atteso della variazione del logaritmo della ricchezza, $E[\Delta \ln(x)]$. Questo stabilisce un ponte formale tra l’approccio dinamico dell’EE e l’approccio statico dell’EUT, ma con un’interpretazione radicalmente diversa.
Risoluzione dei Paradossi
Uno dei punti di forza rivendicati dall’EE è la sua capacità di risolvere numerosi paradossi e anomalie dell’economia tradizionale in modo naturale, senza dover invocare bias cognitivi o preferenze psicologiche complesse.
- Paradosso di San Pietroburgo: Il gioco offre un valore atteso infinito, ma le persone non sono disposte a pagare molto per parteciparvi. L’EE spiega questo comportamento osservando che, sebbene il valore atteso diverga, il tasso di crescita temporale della ricchezza di un giocatore è finito e modesto, giustificando una bassa disponibilità a pagare.
- Equity Premium Puzzle: Il fatto che i rendimenti azionari storici siano stati molto più alti di quelli dei titoli di stato sembra richiedere, nell’ambito dell’EUT, un livello di avversione al rischio irrealisticamente elevato. L’EE suggerisce che il premio non riflette una paura psicologica, ma una compensazione necessaria per la non-ergodicità dei rendimenti azionari (dinamica moltiplicativa) rispetto a quelli più additivi dei bond.
- Puzzle della Cooperazione: L’EE propone che la cooperazione (ad esempio, la condivisione di risorse) possa emergere come strategia razionale perché riduce la volatilità delle traiettorie individuali. In un sistema moltiplicativo, ridurre la volatilità aumenta direttamente il tasso di crescita temporale, anche se il rendimento atteso non cambia. La cooperazione, quindi, non richiede altruismo, ma è una strategia di crescita ottimale in un mondo non ergodico.
In tutti questi casi, l’EE reinterpreta comportamenti apparentemente irrazionali o anomali come risposte perfettamente logiche e ottimali alle dinamiche non ergodiche dell’ambiente in cui le decisioni vengono prese.
2.3. Un Dibattito Acceso: Critiche, Repliche e Confronto con l’EUT
L’emergere dell’Ergodicity Economics ha scatenato un intenso dibattito accademico, con critiche significative provenienti dall’economia mainstream.
Critiche all’Ergodicity Economics
Le principali obiezioni all’EE possono essere raggruppate in tre categorie:
- Mancanza di Novità e Sovrapposizione con il Criterio di Kelly: Molti economisti sottolineano che l’idea di massimizzare il tasso di crescita a lungo termine non è nuova. Già nel 1956, John L. Kelly Jr., basandosi sulla teoria dell’informazione, propose il Criterio di Kelly, una strategia di scommessa che massimizza il tasso di crescita logaritmico del capitale. È stato ampiamente dimostrato che il Criterio di Kelly è equivalente a un agente che opera secondo l’EUT con una funzione di utilità logaritmica, $u(x) = \ln(x)$. I critici, quindi, accusano l’EE di essere una riscoperta o un rebranding di concetti già noti. Inoltre, economisti come Paul Samuelson hanno criticato ferocemente l’idea che la massimizzazione della crescita logaritmica debba essere un obiettivo universale, sostenendo che ignora le legittime e diverse preferenze di rischio degli individui.
- Accusa di Pseudoscienza: Una critica più severa, formalizzata dall’economista Alexis Akira Toda, etichetta l’EE come pseudoscienza. Toda sostiene che l’EE non ha ancora prodotto previsioni uniche e falsificabili che la distinguano nettamente dall’EUT. Secondo questa visione, l’EE soddisfa diversi indicatori di pseudoscienza, come l’uso di un linguaggio talvolta vago e la tendenza a personalizzare le questioni scientifiche.
- Critica di Falsità e Incompletezza: L’analista Michael Dickens porta la critica un passo oltre, sostenendo che il principio ergodico, come formulato dall’EE, è sia infalsificabile che falso. È infalsificabile perché, in molti scenari, le sue prescrizioni sono identiche a quelle di un agente EUT con utilità logaritmica. È falso perché impone una singola strategia normativa (massimizzare la crescita geometrica) a tutti gli agenti, negando la realtà empirica che persone diverse hanno tolleranze al rischio diverse. Dickens sostiene inoltre che il framework dell’EE è matematicamente incompleto, poiché non fornisce un principio per scegliere la trasformazione ergodica corretta tra le infinite possibili.
Il Conflitto tra Fisica e Psicologia come Modello Esplicativo
Al di là delle accuse, il dibattito tra EUT ed EE rivela una divergenza fondamentale sulla natura stessa della razionalità e dell’avversione al rischio.
- La Teoria dell’Utilità Attesa colloca la spiegazione dell’avversione al rischio all’interno della psiche dell’individuo. Un agente è avverso al rischio perché possiede una preferenza psicologica soggettiva, codificata dalla concavità della sua funzione di utilità. L’avversione al rischio è un tratto del carattere.
- L’Ergodicity Economics, al contrario, sposta la causa all’esterno, nell’ambiente. Un agente rifiuta una scommessa con valore atteso positivo ma tasso di crescita temporale negativo non a causa di una preferenza psicologica, ma come risposta matematica e razionale alla dinamica fisica del sistema in cui opera. L’avversione al rischio non è psicologia, ma fisica.
Questa distinzione è cruciale. Se l’EE fosse corretta, molti comportamenti etichettati come bias cognitivi dall’economia comportamentale potrebbero essere reinterpretati come decisioni perfettamente razionali e ottimali, prese all’interno di un mondo non ergodico che i modelli tradizionali non descrivono adeguatamente. Il problema si sposterebbe dall’irrazionalità dell’agente all’inadeguatezza del modello economico.
| Criterio di Confronto | Teoria dell’Utilità Attesa (EUT) | Ergodicity Economics (EE) |
|---|---|---|
| Metrica Decisionale | Massimizzazione del valore atteso dell’utilità (Media d’Insieme). | Massimizzazione del tasso di crescita nel tempo (Media Temporale). |
| Origine dell’Avversione al Rischio | Preferenza psicologica soggettiva (tratto dell’agente). | Risposta razionale alla dinamica fisica del sistema (proprietà dell’ambiente). |
| Focus Analitico | Statico: valutazione di probabilità in un singolo istante. | Dinamico: evoluzione della ricchezza lungo una traiettoria temporale. |
| Fondamento Disciplinare | Psicologia e Teoria della Probabilità. | Fisica Statistica e Teoria dei Sistemi Dinamici. |
| Criticità Principale | Assume implicitamente l’ergodicità; non spiega alcuni paradossi senza ricorrere a bias. | Accusata di scarsa novità (Criterio di Kelly) e di non essere un paradigma scientifico falsificabile. |
Parte III: Analisi Empirica dell’Ergodicità nelle Serie Storiche Finanziarie
3.1. Ergodicità come Condizione per l’Inferenza Statistica
Fondamenti Econometrici
L’analisi econometrica delle serie storiche finanziarie si basa su un presupposto fondamentale: che sia possibile trarre conclusioni generali sulle proprietà di un processo stocastico osservando una singola, finita realizzazione storica di quel processo. Questa inferenza dal particolare al generale è valida solo se il processo sottostante soddisfa due condizioni chiave: stazionarietà ed ergodicità.
- Stazionarietà: Un processo è stazionario (in senso debole) se la sua media, la sua varianza e la sua autocovarianza non dipendono dal tempo. Questa proprietà assicura che le caratteristiche statistiche del processo siano stabili, rendendo i dati passati pertinenti per il futuro.
- Ergodicità: In questo contesto, l’ergodicità è una condizione più forte che riguarda la memoria del processo. Un processo ergodico ha una memoria sufficientemente debole su lunghi orizzonti temporali, tale che osservazioni molto distanti nel tempo possono essere considerate quasi indipendenti. Questa proprietà garantisce che una singola serie storica, se abbastanza lunga, sia rappresentativa dell’intero insieme di possibili traiettorie che il processo avrebbe potuto generare.
Insieme, stazionarietà ed ergodicità forniscono la base teorica per stimare parametri come la media o la volatilità dei rendimenti utilizzando le medie campionarie calcolate sui dati storici. Tuttavia, mentre esistono metodi consolidati per testare la stazionarietà, testare direttamente l’ergodicità da una singola serie storica è teoricamente problematico e spesso impossibile.
Metodologie di Test
Data questa difficoltà, la pratica econometrica si affida a test per proprietà correlate, in particolare la stazionarietà, che è una condizione necessaria per l’ergodicità.
- Test di Radice Unitaria: Questi test sono progettati per determinare se una serie storica è non stazionaria a causa della presenza di una radice unitaria. Un processo con una radice unitaria, come un random walk, ha una memoria infinita e la sua varianza cresce nel tempo, violando la stazionarietà. I test più comuni includono l’Augmented Dickey-Fuller (ADF) e il Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS).
- Test Non Parametrici: Per superare le limitazioni dei modelli parametrici, sono stati sviluppati test non parametrici. Il Wald-Wolfowitz (Runs Test) può essere usato per verificare l’ipotesi di casualità, confrontando le distribuzioni di diverse sotto-sezioni di una lunga serie storica. Ricerche più recenti hanno sviluppato test formali per il fallimento dell’ergodicità in processi markoviani.
3.2. Evidenze Empiriche dai Mercati
L’applicazione di queste metodologie a dati finanziari reali ha prodotto un quadro complesso, in cui l’ipotesi di ergodicità sembra valere in alcuni contesti ma essere palesemente violata in altri.
Redditività Aziendale
Uno degli studi empirici più significativi e recenti sull’ergodicità in finanza è quello di Mundt, Alfarano e Milaković (2022) sulla redditività delle imprese statunitensi. Lo studio avanza una tesi forte: la redditività aziendale (misurata dal Return on Assets – ROA) è ergodica a condizione della sopravvivenza a lungo termine dell’impresa. Mentre le imprese giovani mostrano grande eterogeneità, quelle che sopravvivono per oltre due decenni tendono a convergere verso una distribuzione di redditività comune e stabile. L’implicazione è che la competizione di mercato agisce come un potente meccanismo selettivo. Le imprese che deviano persistentemente dalla norma vengono eliminate. Le sopravvissute sono quelle che si conformano a un regime ergodico di redditività, where la fortuna passata non garantisce un successo futuro superiore alla media del gruppo.
Indici Azionari
L’analisi degli indici azionari presenta un quadro diverso, spesso legato all’ipotesi di mercato efficiente (Efficient Market Hypothesis – EMH). Molti studi empirici, utilizzando test di radice unitaria, concludono che i prezzi degli indici azionari (o i loro logaritmi) seguono un processo di random walk. Un random walk è per definizione non stazionario e, di conseguenza, non ergodico. Uno studio sulla Borsa di Budapest mostra che, sebbene l’indice segua un random walk (e sia quindi non ergodico), il mercato può essere considerato efficiente in forma debole (i prezzi passati non aiutano a prevedere quelli futuri). L’incertezza e l’imprevedibilità del random walk sono proprio ciò che caratterizza un mercato efficiente, in netto contrasto con la prevedibilità statistica implicita in un sistema ergodico.
Tassi di Cambio
I mercati valutari sono forse quelli where l’ipotesi di ergodicità è più debole. Sono notoriamente soggetti a interventi delle banche centrali, cambiamenti di regime politico-economico e crisi improvvise, che si manifestano nei dati come rotture strutturali. Questi eventi violano palesemente l’assunzione di stazionarietà, poiché le proprietà statistiche del processo cambiano drasticamente dopo una rottura. Di conseguenza, l’ipotesi di ergodicità è difficilmente sostenibile. La natura non ergodica dei tassi di cambio implica che i modelli econometrici basati esclusivamente su dati storici hanno un potere predittivo molto limitato.
3.3. Implicazioni per la Pratica Finanziaria
La distinzione tra sistemi ergodici e non ergodici ha implicazioni profonde e dirette per la gestione degli investimenti e la valutazione del rischio.
Gestione del Rischio e Rischio di Rovina
Riconoscere la non-ergodicità dei mercati finanziari sposta radicalmente il focus della gestione del rischio. In un mondo non ergodico, il rischio principale non è la volatilità, ma il rischio di rovina: la possibilità di subire una perdita irreversibile che pone fine alla traiettoria dell’investitore. La priorità strategica diventa quindi la sopravvivenza. Evitare perdite permanenti e catastrofiche ha la precedenza sulla massimizzazione dei guadagni attesi. Questo fornisce una base logica per strategie che enfatizzano la limitazione delle perdite massime (drawdown), come l’uso di stop-loss, opzioni protettive, e l’approccio della Barbell Strategy di Nassim Nicholas Taleb.
Leva Finanziaria Ottimale e Teoria del Portafoglio
La Teoria Moderna del Portafoglio, basata sull’ottimizzazione media-varianza, suggerisce spesso che un investitore dovrebbe usare la massima leva possibile per massimizzare i rendimenti attesi. L’approccio basato sulla media temporale porta a una conclusione radicalmente diversa. Il tasso di crescita a lungo termine (media geometrica) non è una funzione lineare della leva, ma una funzione concava che raggiunge un massimo per un livello di leva finito e poi decresce. Esiste quindi una leva ottimale che massimizza la crescita a lungo termine. Superare questo livello non solo aumenta la volatilità, ma riduce attivamente il tasso di crescita atteso nel tempo, aumentando esponenzialmente il rischio di rovina.
Asset Pricing in Contesti Non-Ergodici
I modelli di asset pricing tradizionali, come il CAPM, si basano su un equilibrio di mercato unico. La non-ergodicità mette in discussione questo pilastro. Studi come quello di Horst e Wenzelburger mostrano che in mercati con agenti eterogenei che interagiscono e si adattano, la dinamica dei prezzi può diventare non ergodica. Possono esistere equilibri multipli, e l’equilibrio a cui il mercato converge può dipendere dalla storia passata. In tali sistemi, il concetto di un unico prezzo di equilibrio o di un rendimento atteso stabile diventa problematico.
Parte IV: Sintesi e Prospettive Future
4.1. Ricomposizione del Mosaico: Ergodicità tra Teoria e Realtà dei Mercati
L’analisi condotta ha messo in luce una profonda tensione. Da un lato, l’ipotesi di ergodicità è un pilastro metodologico che legittima l’uso dell’inferenza statistica per analizzare le serie storiche finanziarie. Senza di essa, l’idea stessa di poter apprendere dal passato diventa problematica. Dall’altro lato, la natura intrinseca dei mercati — caratterizzati da crescita, crisi e la presenza di stati di rovina — suggerisce che essi siano sistemi fondamentalmente non ergodici, where la storia conta e le medie d’insieme non rappresentano il destino dell’individuo. In questo contesto, il programma di ricerca dell’Ergodicity Economics ha svolto un ruolo cruciale. Indipendentemente dal giudizio finale sulla sua originalità, il suo merito innegabile è stato quello di portare il problema dell’ergodicità al centro del dibattito, costringendo la teoria economica a un esame di coscienza critico. Tuttavia, le vigorose critiche ricevute indicano che il suo percorso per affermarsi come un nuovo paradigma è ancora irto di ostacoli. La realtà empirica si rivela più sfumata. Studi come quello sulla redditività aziendale suggeriscono che l’ergodicità potrebbe essere una proprietà emergente, condizionata a specifici regimi, come la sopravvivenza a lungo termine in un mercato competitivo. Allo stesso tempo, l’analisi degli indici azionari e dei tassi di cambio conferma la prevalenza di dinamiche non ergodiche.
4.2. Direzioni di Ricerca Future
Il dibattito sull’ergodicità apre nuove e stimolanti vie di ricerca.
- Modelli Finanziari Non-Ergodici: È necessario sviluppare modelli di asset pricing e gestione del rischio che abbandonino esplicitamente l’assioma ergodico, incorporando caratteristiche come la dipendenza dal percorso e gli eventi estremi (fat tails). Il lavoro sul moto Browniano geometrico generalizzato (gGBM) è un passo in questa direzione.
- Test Empirici e Dati: La validazione delle affermazioni teoriche richiede un impegno continuo sul fronte empirico. Sono necessari test statistici più sofisticati, capaci di distinguere tra diverse forme di non-ergodicità e di identificare transizioni tra regimi.
- Nuovi Concetti: Log-Ergodicità: Un’area di ricerca emergente è quella della log-ergodicità. Questo concetto ipotizza che, sebbene i mercati siano generalmente non ergodici, le azioni di policy maker e banche centrali possano indurre temporaneamente un comportamento più regolare e quasi-ergodico. La log-ergodicità propone operatori matematici in grado di estrarre questa componente di ergodicità nascosta dai dati, offrendo un nuovo approccio per la modellizzazione in condizioni non standard.
Verso una Teoria Contesto-Dipendente della Razionalità
Forse la prospettiva più affascinante è la possibilità di superare la rigida dicotomia tra i modelli esistenti. L’evidenza che l’ergodicità stessa possa essere uno stato condizionale o transitorio del sistema suggerisce una via d’uscita. Una direzione futura potrebbe essere lo sviluppo di una teoria della razionalità che sia essa stessa dinamica e contesto-dipendente. In un tale framework, un agente razionale non sarebbe definito da una singola funzione di utilità o da un unico obiettivo di massimizzazione. Piuttosto, la razionalità consisterebbe nella capacità di adattare la propria strategia decisionale in base al regime dinamico percepito. Un agente potrebbe comportarsi come un massimizzatore del valore atteso in un ambiente percepito come stabile ed ergodico, passare a una strategia di massimizzazione della crescita temporale (simile al Criterio di Kelly) in un ambiente volatile, e adottare una strategia di minimizzazione della rovina (come la Barbell Strategy) quando percepisce di essere vicino a una barriera assorbente. La razionalità non sarebbe più una proprietà statica dell’agente, ma una proprietà emergente e adattiva dell’interazione tra l’agente e il suo ambiente in continua evoluzione. Un tale approccio potrebbe finalmente riconciliare la flessibilità psicologica dell’EUT con la profonda intuizione fisica dell’EE, riconoscendo che in un mondo complesso, la strategia ottimale non è fissa, ma dipende dal gioco a cui si sta giocando.